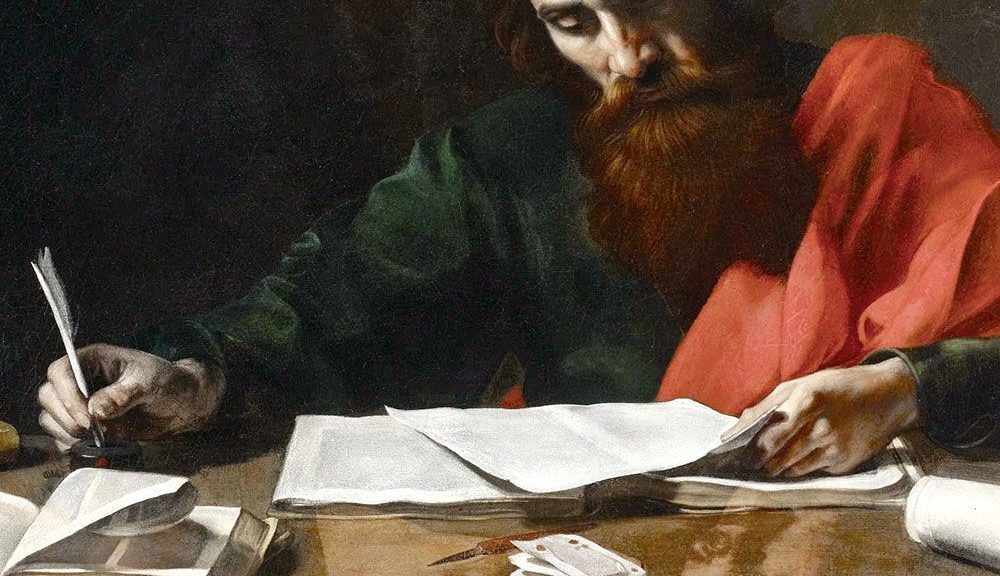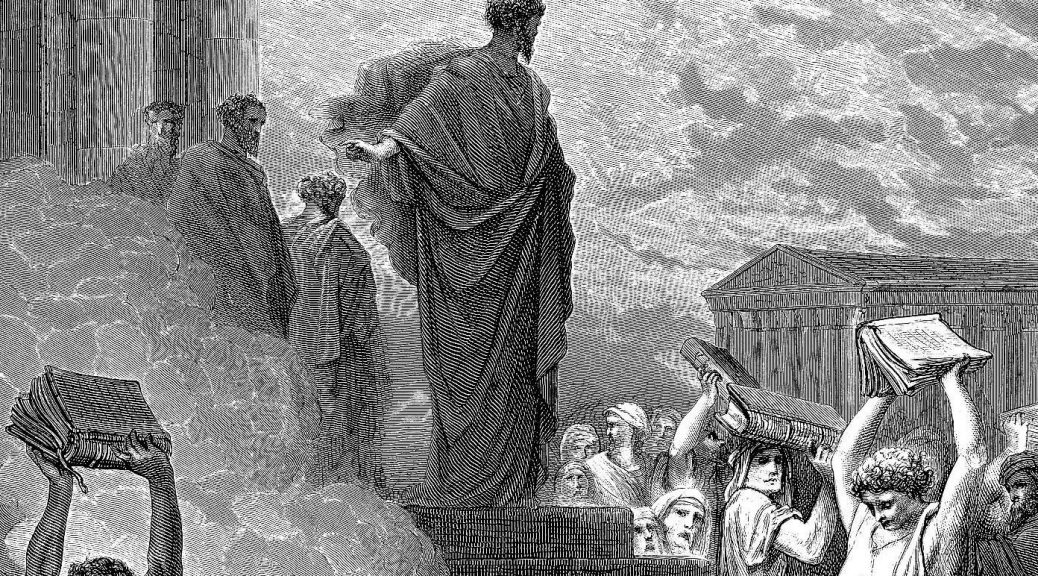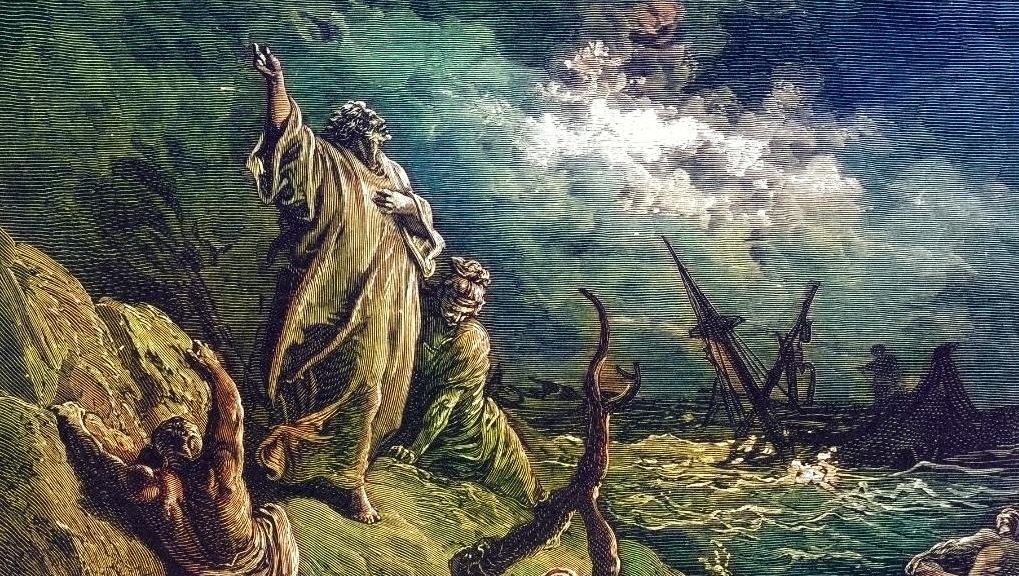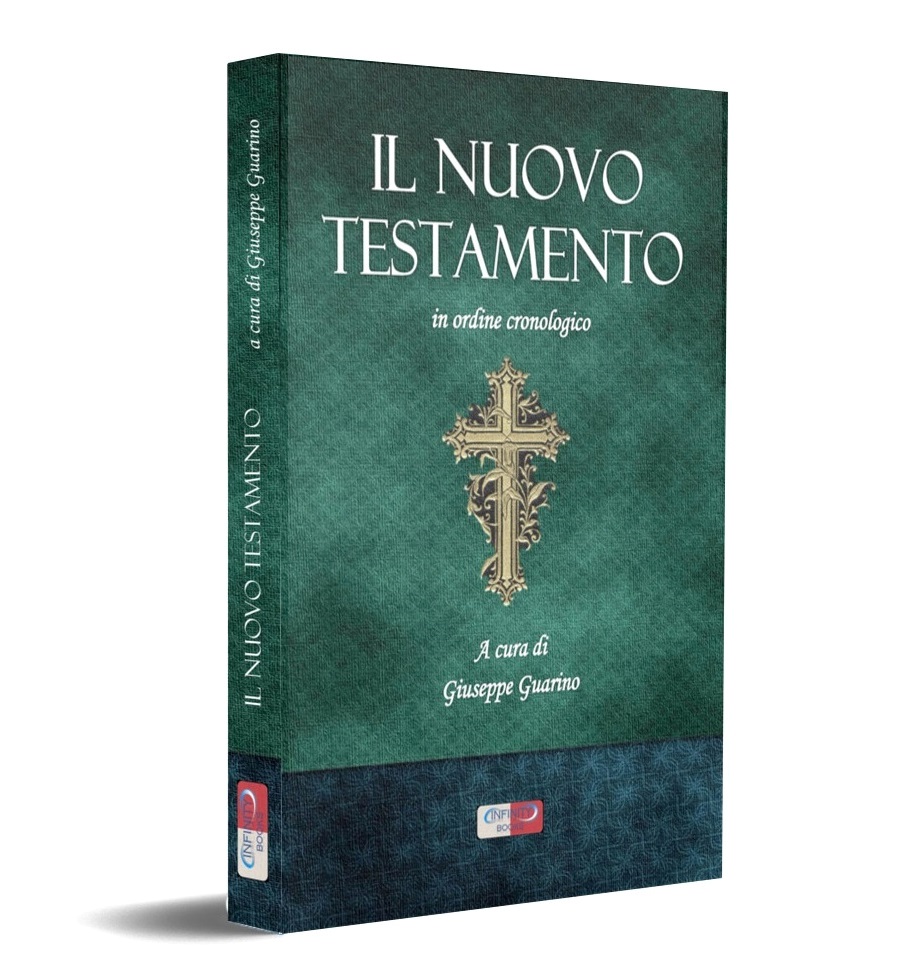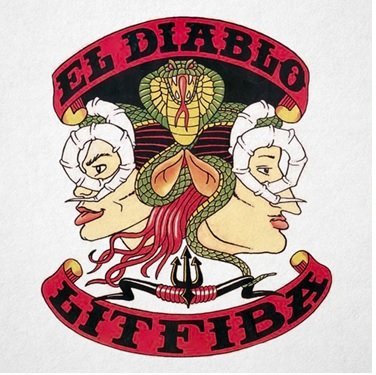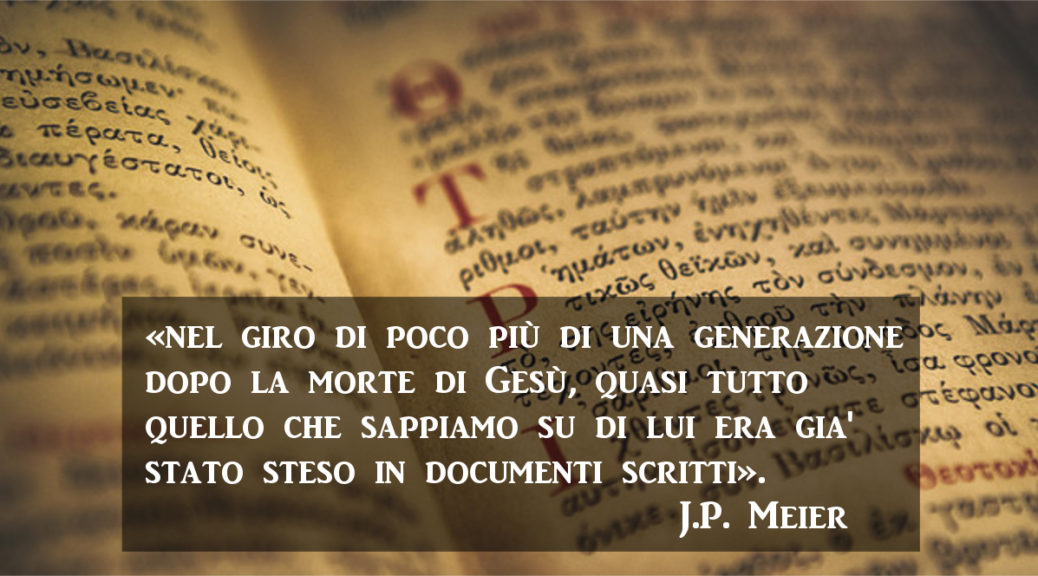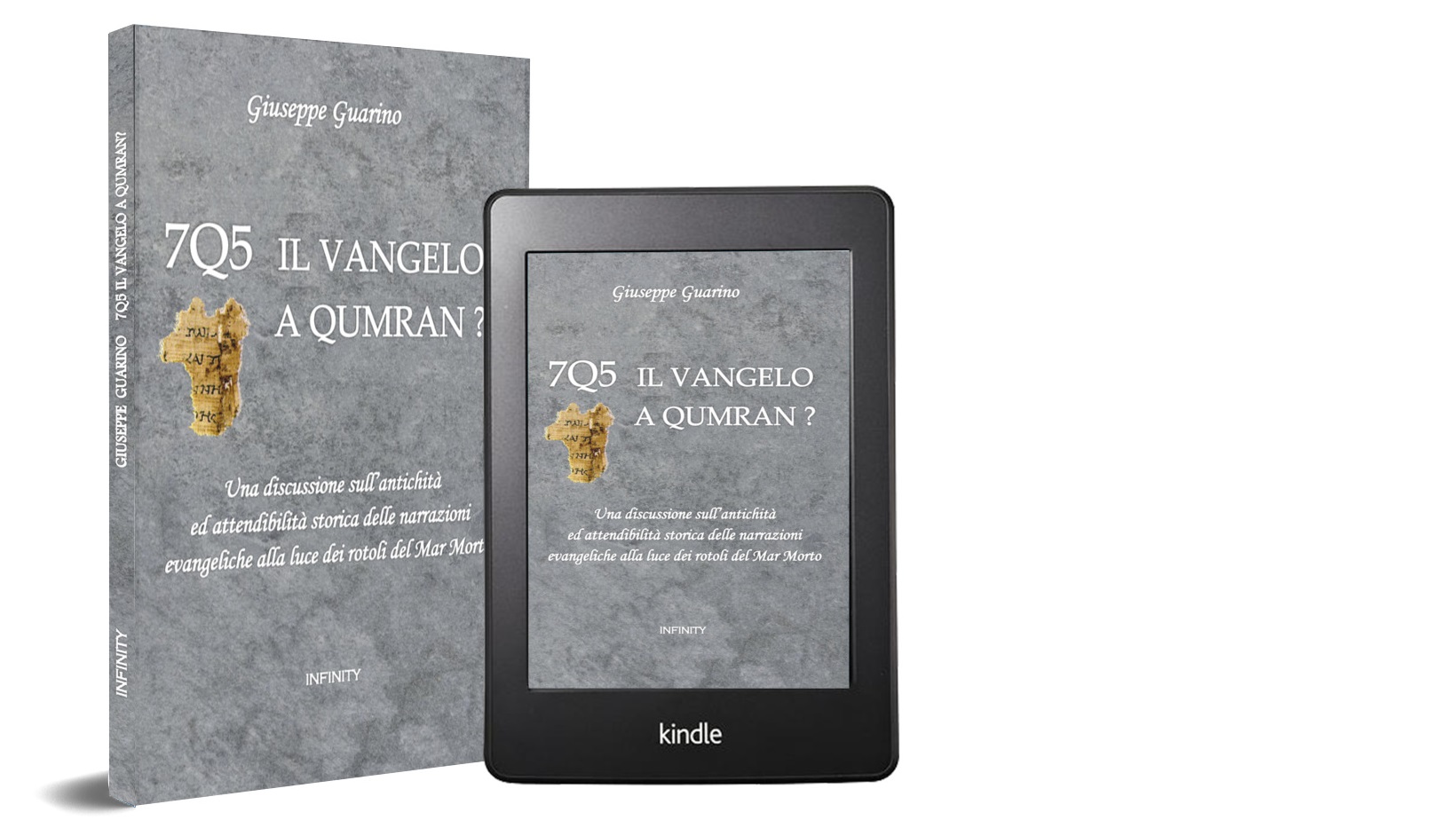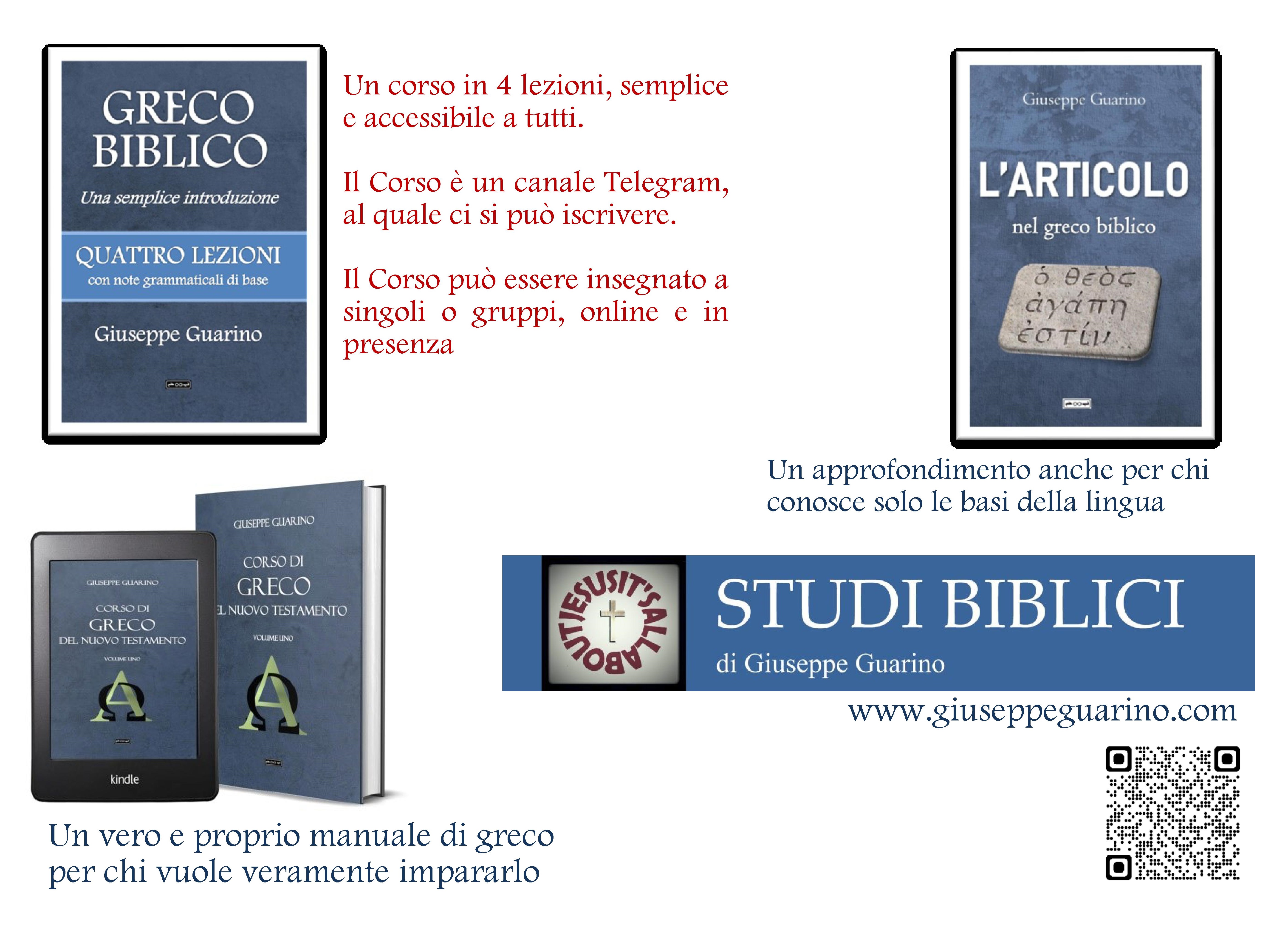di Giuseppe Guarino
versione pdf dell’articolo per una migliore lettura dei termini in originale greco ed ebraico
Giuseppe Guarino Genesi 1,26 www.giuseppeguarino.com
“Poi Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”. Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina”.
Vi sono varie teorie su quel plurale iniziale, quel “facciamo”, davvero di oggettiva difficile comprensione. Secondo alcuni si tratta di una forma di plurale maiestatis. Secondo altri, Dio si rivolge agli angeli. Per chi crede nella deità del Figlio di Dio, eterno creatore con il Padre e lo Spirito Santo, questa espressione è un’ulteriore prova della presenza dell’uno/tre al momento della creazione.
Ma Mosè, o, in ultima analisi, l’autore del libro della Genesi, poteva immaginare e descrivere un’idea tanto complessa e certamente a lui aliena?
Questo dipende da quanto consideriamo determinante l’ispirazione del testo biblico.
Andiamo a vedere Genesi 1:1,
“In principio Dio creò il cielo e la terra”.
In ebraico
בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃
Le peculiarità numeriche del primo verso della Bibbia hanno colpito più di una persona.
Il verso contiene 7 parole e 28 lettere. 28= 7 x 4
Le prime tre parole sommano 14 lettere= 7 x 2
Le seconde quattro sommano anch’esse 14 lettere= 7 x 2
Le prime tre parole (3=perfezione) sono in se stesse complete: il quando, l’azione ed il soggetto. Le 4 parole che seguono sono il cosa, introdotto dalla parola ebraica intraducibile, את, che precede il complemento oggetto.
3 è il numero di Dio (Santo, Santo, Santo, se non vogliamo menzionare la sua trinità) e 4 è il numero della terra (i 4 canti della terra citati più volte, ecc.). Il primo verso narra anche numericamente della perfezione di Dio e della creazione della terra.
Possiamo immaginare che l’autore di Genesi si sia personalmente scervellato per riuscire ad ottenere un risultato tanto matematicamente perfetto e significativo per veicolare il pensiero di Dio?
Ivan Panin è famoso per essersi convertito dall’agnosticismo alla fede nella Bibbia come Parola di Dio ispirata, proprio perché ne ha scoperto la perfezione matematica nella ricorrenza del numero 7 in maniera davvero soprannaturale, tanto nel testo ebraico dell’Antico Testamento quanto in quello greco del Nuovo.
Qualcosa di simile è avvenuta a studiosi di altre materie. C’è chi indagando sull’inattendibilità dei vangeli, alla fine ha scoperto che la verità è invece che sono dei resoconti di prima mano ed autentici.
Anche scientificamente, in base a quanto sappiamo oggi ovviamente, la Bibbia si mostra corretta in dettagli impensati.
Amo molto la storia antica, e mi ha sorpreso scoprire quanto la Bibbia sia accurata dal punto di vista storico. In realtà non ho problemi ad affermare che essa è il documento storico più antico ed attendibile che possediamo. Maggiore è stato il numero di ritrovamenti archeologici, maggiore è stata la conferma dell’accuratezza storica della Bibbia.
Davanti a questi dati, sebbene riconosciamo anche la valenza dell’elemento umano, non possiamo non riconoscere il sigillo dell’ispirazione divina delle Sacre Scritture.
Restando in Genesi, e volendo ribadire che l’ispirazione permette di superare alcuni vincoli legati all’umanità dell’autore sacro, consideriamo il cosiddetto protovangelo:
“Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei; questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno” (Genesi 3:15).
È opinione radicata nella Chiesa, che questo brano si riferisca alla morte del Signore Gesù ed al suo trionfo su Satana con la sua meravigliosa resurrezione.
Difficile pensare che qui l’ispirazione divina non abbia prevalso sull’elemento umano. A meno che Dio non abbia dato a Mosè una specifica rivelazione che spiegava il senso delle parole di questo verso.
In altri punti, Mosè dice più di ciò che potrebbe intendersi da una lettura superficiale. Egli scrive in più punti, ed in maniera tanto significativa che non può intendersi casuale: “Dio disse”. Vedi Genesi 1:3, 6, 11, 14, 20, 24.
“Dio disse” al v. 26 è la settima occorrenza di questa espressione.
Quello che poi scriverà Giovanni nel suo Vangelo era già stato intuito ed espresso dai commentatori ebraici.
“In principio era la Parola… per mezzo di lei ogni cosa è stata fatta”.
Nessuno crede più al fatto che Giovanni abbia attinto alla cultura greca, al logos dei filosofi. Semmai è vero il contrario, i filosofi greci hanno attinto alla cultura orientale ed ebraica per sviluppare la loro teoria di un logos, un tramite fra Dio e la sua creazione.
I sumeri avevano l’idea di una “parola” potenza creatrice (“enem”). Il concetto venne trasmesso agli accadi (“awatu”). Questo millenni prima dei greci. (fonte: William F. Albright, From the Stone Age to Christianity)
Filone alessandrino, “filosofo” ebreo vissuto ad Alessandria d’Egitto, parla apertamente del “logos” in termini molto simili a quelli del Nuovo Testamento. Egli affermava che Mosè era il detentore della vera filosofia e che i greci vennero dopo di lui.
Anche la cultura giudaica aveva già visto nella Torah la “parola”, Davar (דבר) in ebraico. Per questo Giovanni ne parla nel suo vangelo dando per scontato che chi leggeva sapesse di cosa lui stesse parlando. Ed era così: i greci per via delle speculazioni filosofiche, gli ebrei per via dell’interpretazione del tempo.
Il Targum è una parafrasi in aramaico dell’Antico Testamento che usa “parola”, in aramaico “memra”, utilizzando questo termine quando Dio interagisce con la sua creazione.
Leggiamo sul sito https://www.sefaria.org/Targum_Jonathan_on_Genesis.3?lang=bi la parafrasi di Genesi 3:8, “Ed essi udirono la voce della Parola (aram. מֵימְרָא, Memra) del Signore Dio che camminava nel giardino…”
Quando Mosè scriveva queste cose meravigliose, era totalmente consapevole dei profondi significati e del valore profetico di ciò che riportava?
Quando, quindi, leggiamo le parole di Genesi 1:26 e anche queste ci colpiscono, non dobbiamo sorprenderci se esse hanno significati talmente grandi che ci conducono a verità rivelate solo con la venuta di Gesù ed il Nuovo Testamento.
Non fu Gesù stesso a dire che Mosè aveva scritto di lui? Vedi Giovanni 5:46. E dove aveva scritto di lui? In quale modo se non profetico e nei profondi significati dei suoi scritti che oggi comprendiamo appieno grazie alla guida dello Spirito Santo?
Torniamo al nostro soggetto iniziale: quando Dio dice “Facciamo l’uomo a nostra immagine”, con chi parla?
La chiave di lettura, come spesso succede con la Bibbia, ce la fornisce un attento esame del testo e la luce della piena rivelazione in Cristo che ci tramanda il Nuovo Testamento.
Dire qui che il Padre conversava con il suo Figlio Unigenito è perfettamente coerente con quanto ci insegna l’apostolo Giovanni e conferma Paolo nelle sue epistole.
“Egli era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui; e senza di lui neppure una delle cose fatte è stata fatta.” (Giovanni 1:2,3) – La traduzione è mia. Di solito questo verso è riferito al femminile, perché il termine greco originale logos, maschile, viene giustamente tradotto con parola, che è femminile.
Se tutto è stato creato mediante il logos di Dio, il suo Figlio Unigenito, lo è stato anche l’Uomo.
“Per mezzo di lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e invisibili.” (Colossesi 1:16)
Vi è una stupenda immagine relativa alla creazione dell’uomo.
“Dio il SIGNORE formò l’uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l’uomo divenne un’anima vivente.” (Genesi 2:7)
Chi soffiò l’alito della vita nell’uomo?
Come spesso accade, andiamo a trovare chiarimenti nel Nuovo Testamento.
“Allora Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre mi ha mandato, anch’io mando voi”. Detto questo, soffiò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo””. (Giovanni 20:21, 22)
Il medesimo agente del Padre, il logos (Parola, Verbo) che soffiò l’alito vitale nelle narici per dare vita all’uomo all’alba del tempo, qui lo fa per dar vita al nuovo uomo, rigenerato dallo Spirito di Dio. (vd. Giovanni 3:1-15, Efesini 4:24, 2 Corinzi 5:17, Galati 6:15)
Il soffio, il vento, è in generale un chiaro riferimento allo Spirito. In tutta la scrittura. È un riferimento implicito nei termini originali utilizzati: in ebraico ruah (רוח) ed in greco pneuma (πνευμα).
Per spiegarlo con grande semplicità, possiamo riportare alla mente il nostro vocabolo “pneumatico”, esso deriva chiaramente dal greco e il suo uso è dovuto all’aria che lo riempie ed è essenziale per il suo uso.
Il verbo utilizzato qui per l’azione compiuta da Gesù, il soffiare sui discepoli è ἐνεφύσησε, il medesimo utilizzato in Genesi 2:7 nella traduzione greca della Torah, la LXX (Settanta).
Il riferimento è troppo esplicito e non può essere casuale.
Non ho mai portato gli occhiali in vita mia. Ma, come spesso accade, il passare degli anni, meglio di qualsiasi altra cosa, ci ricorda che siamo umani. Oggi devo indossare gli occhiali per vedere bene da vicino. A volte faccio lo splendido e non li metto e lavoro comunque. Poi, però, finisce che, se avessi indossato gli occhiali, non avrei commesso delle sviste paurose.
Lo stesso è con la Scrittura. Per capirla abbiamo bisogno di indossare gli occhiali dello Spirito! E per capire l’Antico Testamento dobbiamo indossare gli occhiali del Nuovo!
“Allora aprì loro la mente per capire le Scritture” (Luca 24:45). Se non leggiamo la Bibbia alla luce di Cristo, non potremo capirla. Come dice Paolo: “Ma le loro menti furono rese ottuse; infatti, sino al giorno d’oggi, quando leggono l’antico patto, lo stesso velo rimane, senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito.” (2 Corinzi 3:14)
La comprensione delle Scritture non si ottiene studiando. In fatti la Scrittura parla di coloro che si sforzano “sempre d’imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità”. (2 Timoteo 3:7)
Il velo è rimosso solo in Cristo e grazie al suo Spirito in noi possiamo comprendere la Verità delle Scritture.
Non è quindi nessuna sorpresa se adesso, alla luce di tutta la Scrittura, vediamo in Genesi Dio che tramite il suo Logos e lo Spirito Santo creano l’uomo. (Genesi 2:7) Quanto è meravigliosa la Parola di Dio, profonda; parla al nostro spirito confermando la nostra fede e aumenta il nostro entusiasmo per le cose di Dio.
Senza gli occhiali della fede in Cristo, queste cose rimarranno per sempre incomprensibili.
Infatti, nonostante Gesù annunciasse la Parola con libertà, solo alcuni si avvicinavano a lui e si sforzavano di comprendere il significato vero e profondo di ciò che dicevano: “Egli rispose loro: “Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli; ma a loro non è dato.” (Matteo 13:11).
I discepoli non avevano nessuna superiorità intellettuale rispetto agli altri, ma andavano dal loro maestro e lo interrogavano per capire, avevano desiderio di sapere e si rivolgevano alla fonte della sapienza, colui che nell’Antico Testamento era stato identificato con la Sapienza stessa!
Gli altri andavano a casa loro, presi dalla loro quotidianità. Alcuni, magari, nella loro presunzione, credevano di aver capito tutto. Altri forse andavano ad interrogare i loro rabbini, i maestri religiosi nei quali avevano fiducia.
Genesi 1:27 legge:
Dio creò l’Uomo a sua immagine
lo creò ad immagine di Dio
li creò maschio e femmina
Se ci fermiamo al verso 26 perdiamo altri dettagli a mio avviso importanti. Questo passaggio da singolare a plurale nel verso 27 è piuttosto interessante e pertinente con la nostra discussione. Dio (Elohim) crea l’Uomo, singolare. Ma questo singolare, ad immagine di Dio, è anche un plurale, maschio e femmina.
L’unità fra uomo e donna è descritta poco più avanti, quando la creazione dell’uomo e della donna (dell’Uomo) è vista in dettagli di una poesia ed universalità ineguagliata da nessuna altra narrazione epica, mitologica o scientifica.
“Dio il SIGNORE formò l’uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l’uomo divenne un’anima vivente. […] Allora Dio il SIGNORE fece cadere un profondo sonno sull’uomo, che si addormentò; prese una delle costole di lui, e richiuse la carne al posto d’essa. Dio il SIGNORE, con la costola che aveva tolta all’uomo, formò una donna e la condusse all’uomo. L’uomo disse: “Questa, finalmente, è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall’uomo”. Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno una stessa carne”. (Genesi 2:7, 21-24)
Profondissimi significati spirituali vengono espressi con una elegantissima ed allo stesso tempo efficace poesia.
L’unità dell’Uomo, composto da uomo e donna uniti, è definita con il termine ebraico: אחד, nel nostro alfabeto traslitterato come ‘echad.
Questo medesimo vocabolo lo ritroviamo nella confessione di fede ebraica, lo Shemà Israel. Questa la ribadì a gran voce lo stesso Gesù durante il suo ministero. Ho consultato la traduzione ebraica ufficiale in inglese di Deuteronomio 6:4 ed essa recita:
Ascolta, Israele:
Il Signore nostro Dio
Il Signore è uno
Questa versione preserva la ritmica del testo ebraico che si conclude affermando che Dio è “uno”. La parola ebraica utilizzata qui per dire che il Signore è “uno” è, come per l’Uomo (uomo e donna) אחד, ‘echad.
Come Uomo è un termine che include uomo e donna (v.27) che sono ‘echad, uno, allo stesso modo Dio, Elohim, (v.26) nel dire “facciamo” non fa altro che riferirsi alla sua ‘echad, di cui fanno parte il Figlio e lo Spirito Santo.
Credo che sia strabiliante, come già nelle prime pagine della Parola di Dio compaia subito così meravigliosamente coinvolto nella sua interazione con il mondo che crea, da farlo con la totalità della sua unità.
Al verso 1 troviamo il termine Elohim, che in teoria in ebraico non sarebbe esattamente un singolare, seguito da un verbo al singolare. Al v.2 è lo Spirito di Dio che si muoveva sopra le acque. Al v.3 ecco che la Parola, di cui parlerà Giovanni, compare quando leggiamo, Dio disse!
Da questo verso in avanti fa la sua fondamentale comparsa il logos, la Parola.
“Nessuno ha mai visto Dio; l’unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è quello che l’ha fatto conoscere.” Giovanni 1:18
Giovanni è lapidario: Dio non lo ha mai visto nessuno.
È naturale che sia i giudei che i primi cristiani abbiano compreso che era il logos (greco) davar (ebraico) memra (aramaico) parola (italiano) verbum (latino) a manifestarsi, manifestando Dio.
Infatti di chi era la voce in Genesi 3:8? E chi camminava nel giardino? Dalla presenza di chi si nascosero Adamo ed Eva?
Chi fa – fa! – delle tuniche di pelle per vestire l’Uomo? Il brano non dice che queste tuniche vengono create, quindi dobbiamo dedurne che un animale sia stato ucciso per ottenerle. Dio stesso rimedia alla nudità dell’Uomo – al danno che ha fatto con il peccato!
Qui Mosè parla profeticamente dell’opera di salvezza di Dio, che sarebbe stata un giorno compiuta per mezzo di Gesù, logos di Dio fatto uomo! Ed anche qui in Genesi, l’agente tramite il quale Dio rimedia alla nudità dell’uomo, non può non essere la Sua Parola.
In tutto il libro dell’Apocalisse, il vestire è descrittivo dello stato di grazia e salvezza – vd. Ap. 3:18, 4:4, 7:9,14, 16:15, 22:14. E sono dei riferimenti significativi, perché molto di quello che il peccato distrugge in Genesi, viene ripristinato in Apocalisse.
Di nuovo, quasi alla fine della drammatica scena della caduta dell’Uomo, troviamo quel plurale che per la prima volta avevamo visto in Genesi 1:26,
Ecco, l’uomo è diventato come uno di noi,
quanto alla conoscenza del bene e del male
Ora la frase non ci può apparire così enigmatica, ma, alla luce di quanto abbiamo visto, perfettamente coerente. I “noi” sono l’ ‘echad in cui sono presenti il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Mi riservo di affrontare in un altro articolo perché questa “conoscenza del bene e del male” ci sia costata l’Eden. Non sembrerebbe così grave, infatti, a prima vista; in realtà la forza dell’espressione semitica è ben altra rispetto a quella delle versioni in italiano. In questo articolo, già di per se piuttosto lungo, preferisco non approfondire anche questo dettaglio – sebbene non sia per nulla secondario, o trascurabile.
Volevo avere un quadro più chiaro sulla frase di Genesi 1:26 e per questo ho intrapreso questa piccola ricerca. Confesso di esserne stato edificato spiritualmente prima, e come studioso poi. Lo stesso spero sia accaduto al lettore.